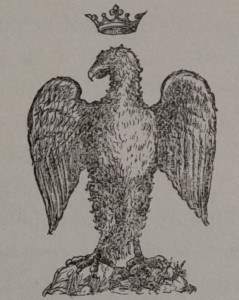UN’ AQUILA CON LE ALI ABBASSATE, IMBECCATA, ARMATA E DIADEMATA DI ROSSO
Spiegazione : L’aquila bianca o d’argento in campo azzurro fu una insegna dei Troiani e dopo, nel secondo consolato di Caio Mario, l’ebbero ancora i Romani nelle insegne delle loro legioni, ed erano detti aquiliferi i portatori di esse. Divenne, poi, un distintivo della Fazione Ghibellina.
Il conte Antonio di Carpegna, signore di Montecopiolo e di S. Leo, fu ghibellino ed ebbe per sua impresa l’aquila di Giove feretrio, perchè divenne signore della terra dove sorgeva il tempio del detto nume. La volle imbeccata, armata e diademata di rosso in memoria del sanguinoso tumulto da lui sedato in Roma contro l’imperatore Barbarossa, dal quale ebbe principio la sua grandezza. Quando la città di Urbino reggevasi con le sue leggi, innalzava nel suo stemma l’aquila imperiale romana.
I Montefeltro, prima della sua conquista, continuavano ancora a portare nel loro stemma le tre bande d’argento in campo azzurro della famiglia dei Carpegna, ma, assoggettata che la ebbero, cambiarono le tre bande in oro e nella banda superiore misero l’aquila degli urbinati, e così i signori feudatari ed i loro sudditi ebbero, da allora, uno stemma comune.
La figura dell’aquila fu sempre un sacro emblema per tutti i Montefeltro, poichè ad essi ricordò la loro origine avuta nelle terre feretrane, il vicariato di queste concesso da Federico Barbarossa al loro capostipite conte Antonio di Carpegna ed il feudo della città di Urbino, ottenuto da essi per elargizione dell’imperatore Federico II di Svevia.
Questo emblema fu da essi innalzato in ogni dove, e nel loro palazzo di Urbino, scolpito in dura pietra, fu messo sull’alto dell’elegante facciata che guarda ad ovest; e quell’aquila, posata fra le due caratteristiche torrette, pare che con disdegnoso sguardo si rivolga tutto all’intorno, minacciando ognuno che ardisse di avvicinarsele.
Questa impresa, perchè fu veramente un simbolo od un emblema, non ebbe il motto.
(Tratto da ‘Le imprese o figure simboliche dei Montefeltro e dei della Rovere”, L. Nardini, 1931, Società Tipografica Editrice Urbinate)